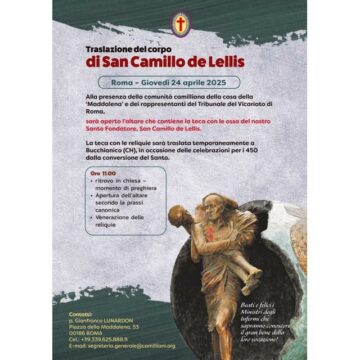In copertina “Assistenza domiciliare Tbilisti” foto di Guillermo Luna
Due testi biblici, uno dell’AT e uno del NT, attestano l’estrema importanza della visita al malato.
In Siracide 7,35 si esorta: “Non esitare nel visitare gli ammalati, perché per questo sarai amato”. Il testo significa che, visitando il malato, l’uomo obbedisce al comando di amare il prossimo ed è a sua volta riamato. In Matteo 25,36 Gesù, giudice escatologico, proclama: “Ero malato e mi avete visitato”. La visita al malato diviene incontro misterioso eppure reale con il Cristo presente nel malato: visitando il malato, si fa l’esperienza del Cristo che ci visita nel malato stesso. Eppure la Bibbia attesta che la visita al malato è operazione delicatissima e rischiosa: i conoscenti che visitano il malato nel salmo 41 diventano i suoi nemici; gli amici che visitano Giobbe in realtà falliscono l’incontro e sono percepiti da Giobbe come “medici da nulla” (Gb 13,4), “consolatori stucchevoli” (Gb 16,2), “raffazzonatori di menzogne” (Gb 13,4), come presenze moleste e nemiche. L’esempio del loro fallimento è istruttivo per molti che volendo fare un’ opera di misericordia corporale pensano che basti la buona intenzione di “fare” tale visita per aver compiuto il bene. Ma la visita al malato non va da sé: è sempre difficile incontrare l’altro, ma ancor più difficile è incontrare in verità il malato.
L’errore degli amici di Giobbe, che spesso è il nostro, consiste nel presentarsi al malato come “salvatori”, cioè nella convinzione di sapere, meglio del malato stesso, ciò che il malato deve fare; nella certezza che, visitando il malato, si sta facendo il bene per lui e davanti a Dio; che si è senza dubbio capaci di consolarlo e di aiutarlo. Spesso poi si va dal malato “a mani piene” e non “a mani vuote”: cioè, armati di strumenti (Bibbia, libro spirituale, doni, eccetera) che più che aiutare un incontro autentico, diventano elementi di difesa e di presa di distanza dall’impotenza del malato. Andando dal malato come “salvatori” gli amici di Giobbe innescano un triangolo perverso in cui fanno del malato una vittima divenendo i suoi persecutori e finendo per divenire a loro volta i bersagli delle accuse e del risentimento di Giobbe.
Così ciascuno dei due attori del dramma (visitatore e malato) appare di volta in volta persecutore e vittima, a partire dalla pretesa del visitatore di essere salvatore, dunque figura di cui il malato ha bisogno. Ma una relazione di necessità e di bisogno esce dalla gratuità e dalla libertà che sono essenziali alla sua riuscita. Per visitare il malato occorre entrare nell’ ottica che non si ha potere sul malato e che solo tentando di condividere, per quanto possibile, la sua impotenza e la sua debolezza, lo si potrà incontrare. Occorre comprendere che il capezzale del malato non è il luogo per una predica o per una lezione di morale o di teologia e che la debolezza del malato non può divenire l’inconscia conferma della propria forza. La visita al malato si situa nello spazio dell’incontro significativo per l’altro, incontro che fa emergere la qualità personale del malato: egli non è un “numero” o un “caso clinico”, ma una persona che vive il drammatico oggi della malattia (5). Guai se la visita divenisse l’occasione con cui il visitatore si sente valorizzato dalla debolezza del malato e rafforzato nella sua significatività! È al malato che si deve lasciare guidare la visita, è lui che deve essere ascoltato, è a lui che deve essere lasciata la parola, è lui il maestro da ascoltare: è in lui che si identifica il Cristo, non nel visitatore (cf. Mt 25,36).
Se poi la visita avviene a domicilio, nella casa del malato, allora ci si deve assolutamente attenere, con infinita discrezione, al quadro relazionale posto  dal malato: i muri della sua casa sono impregnati di ricordi significativi, sono ricchi di storia affettiva, sono lo spazio vitale del malato. Va poi tenuto conto della inevitabile asimmetria tra malato e visitatore: quest’ultimo fa parte del mondo dei “sani”; quando si avvicina al malato che giace nel letto rischia di guardarlo dall’alto in basso, visibilizzando così il potere che ha sul malato: chiunque accompagni un malato sa che deve chinarsi e porsi al livello degli occhi del malato per poter comunicare con lui. Il malato – e qui emerge la fatica della visita autentica – chiede al visitatore di abbassarsi, di indebolirsi, di impoverirsi, gli chiede di entrare in una comunicazione fatta non solo e non tanto di parole, ma soprattutto di silenzio vigile, di ascolto, di discernimento del linguaggio del proprio corpo. Soprattutto nelle situazioni estreme si comunica con gli occhi e con le mani, con lo sguardo e con il tatto.
dal malato: i muri della sua casa sono impregnati di ricordi significativi, sono ricchi di storia affettiva, sono lo spazio vitale del malato. Va poi tenuto conto della inevitabile asimmetria tra malato e visitatore: quest’ultimo fa parte del mondo dei “sani”; quando si avvicina al malato che giace nel letto rischia di guardarlo dall’alto in basso, visibilizzando così il potere che ha sul malato: chiunque accompagni un malato sa che deve chinarsi e porsi al livello degli occhi del malato per poter comunicare con lui. Il malato – e qui emerge la fatica della visita autentica – chiede al visitatore di abbassarsi, di indebolirsi, di impoverirsi, gli chiede di entrare in una comunicazione fatta non solo e non tanto di parole, ma soprattutto di silenzio vigile, di ascolto, di discernimento del linguaggio del proprio corpo. Soprattutto nelle situazioni estreme si comunica con gli occhi e con le mani, con lo sguardo e con il tatto.
Il malato, che spesso è un corpo manipolato e costretto a subire approcci tattili che, pur essendo curativi, sono intrusivi e aggressivi, vedendosi destinatario di gesti di tenerezza e delicatezza, si sente accolto nel suo corpo debole e dunque rispettato nell’intimità del suo essere personale. Così è essenziale al malato il sentirsi accolto nei suoi stati emozionali senza alcun atteggiamento di censura da parte del visitatore. Se la visita al malato è così delicata, è bene non lasciarla in balia dell’improvvisazione e delle buone intenzioni senza discernimento, ma occorrerà sempre, almeno, porsi due domande: perché vado a visitare un malato? Come lo visito? Allora si comprenderà come l’arte della visita all’uomo nella malattia non è solo qualcosa da fare, un’opera facendo la quale noi compiamo il bene sempre e comunque, ma un evento che richiede un profondo lavoro su di sé e un discernimento su ciò che ci abita, sulle motivazioni profonde che ci guidano; in definitiva, su chi siamo e sul senso che hanno gli altri per noi.