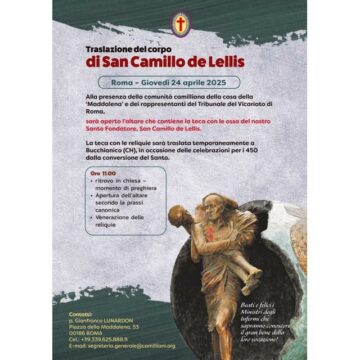Articolo tratto da L’Osservatore Romano  di FEDERICO GIUNTOLI
di FEDERICO GIUNTOLI
«Grazie per questa visita e grazie per la preghiera che voi fate per la Chiesa. Voi fate tanto bene alla Chiesa con le vostre sofferenze, sofferenze inspiegabili. Ma Dio conosce le cose e anche le vostre preghiere». È con queste parole che il Papa il 30 novembre di tre anni fa accolse un gruppo di bambini ammalati di tumore provenienti dalla Polonia. Avere a che fare col cancro, anche per tutto il terribile immaginario collettivo legato a quella parola, per chi ne è affetto significa fare i conti, da una parte, con una sofferenza garantita e ineludibile e, dall’altra, con la percezione che niente più sarà come prima. Il dolore — e ancor più il dolore innocente — è un grido, ora muto ora assordante, che richiede accoglienza. La trafittura e il tormento ad esso legati spesso si inaspriscono quando tale grido non riesce a incontrare un’attenzione, pur timida e inerme, che gli si offra in ascolto.
Tale attenzione può provenire solo dalla compagnia, anche silenziosa — a condizione che sia vera — di un volto umano che si accosti a quello del sofferente.
La malattia, infatti, è sempre più di un fatto clinico, medicalmente circoscrivibile e strumentalmente accertabile. Essa è anzitutto la condizione di una persona: il malato. Grande è la differenza tra l’avere una malattia (un sòma malato) e l’essere malati (un sòma malato che condiziona anche la propria interiorità). Come ci ricorda Lucio Anneo Seneca (4 prima dell’era cristiana – 65) nel suo De brevitate vitae (XVIII , 6): «Per molti causa di morte è stato conoscere il proprio male» (causa multis moriendi fuit morbum suum nosse). Ogni cancro, ovunque colpisca, aggredisce e prolifera sempre nell’interiorità del malato. Per usare un’immagine, nei processi metastatici occorre considerare che le cellule maligne del tumore di origine passano sempre in un nuovo sito di impianto, l’interiorità del paziente.
Questo, a ragion veduta, non si trova nei manuali di anatomia patologica; tuttavia occorre sempre considerarlo nell’iter della cura. È una pura astrazione credere che la sofferenza possa essere distinta in fisica, psichica e spirituale, come se non coinvolgesse, nella realtà delle cose, l’interezza della persona. È per questo motivo che risulterebbe alquanto riduttivo — riduttivo per la stessa attenzione al male fisico — non ascoltare e, dunque, non curare anche i dolori più intimi e riposti che si agitano in un corpo fisicamente sofferente. La malattia oncologica, infatti, irrompendo nell’ordinarietà della vita di una persona attraverso una molteplicità di fasi, che possono andare dal rifiuto, alla ribellione, all’apertura e all’accettazione, si trova, anche solo implicitamente, a evocare domande di senso sull’intero itinerario dell’esistenza umana, dal principio al suo compimento, aiutando a discriminare tra l’autentico e l’ingannevole. Ora, in quanto tale, una domanda di senso sul cosa e sul perché della propria esistenza è già una domanda spirituale, se non già di orizzonte religioso, come in molteplici occasioni ha sostenuto Viktor E. Frankl. Non è soltanto un corpo malato, infatti, ma una vita intera a essere imprigionata dentro la realtà di una diagnosi infausta e, successivamente, in una stanza o in un letto. Non si sta curando solo una parte del suo organismo, ma una persona nella sua interezza che soffre in questo o in quel punto ed esprime tale sofferenza con il suo modo personale di essere, col suo scarso o elevato bagaglio culturale e con l’alfabeto più o meno evoluto delle proprie emozioni e della propria interiorità.
Molte volte la malattia, pur abbrutendo fisicamente, umanizza. Perché questo processo sia incoraggiato e sostenuto occorre favorire nel malato l’accettazione della propria impotenza e della propria limitatezza. Del resto, sta proprio nella lenta e travagliata accettazione di questa limitatezza la potenza della debolezza del paziente, per esprimersi con un ossimoro di ispirazione paolina (cfr. 2 Cor 12, 9-10). Non a caso, infatti, è nella conoscenza e nell’accoglienza del proprio limite l’essenza stessa della vita, ed è proprio la condivisione del riconoscimento e dell’assunzione di questo limite a porre sul medesimo piano il paziente e il suo medico. Se un male può essere considerato “incurabile”, la persona che lo possiede mai lo è.
Spesso, quando ci troviamo dinanzi ad una perdita sul piano fisico e intellettuale, si osserva in modo più o meno evidente un guadagno sul piano affettivo, interiore, spirituale: «Se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno» (cfr. 2 Cor 4, 16). Per esprimere la medesima verità con categorie di sapore aristotelico: «Quando aumenta la forma, diminuisce la sostanza». Se questo è verificabile in una quantità notevole di situazioni, lo è anche per il corpo segnato da una malattia fortemente invalidante. Molte volte, infatti, dentro un corpo martoriato e sfinito dal male — con poca forma, quindi — si possono nascondere e sprigionare forze e risorse inaspettate e inaudite. «Voi fate tanto bene alla Chiesa con le vostre sofferenze, sofferenze inspiegabili»: è il mistero del chicco di grano che, annullandosi nella nuda terra, produce abbondanza di vita (cfr. Gv 12, 24). Questo è forse perché, restringendosi inevitabilmente l’universo di chi sta per morire o di chi è fortemente minato nel proprio soma e divenendo i suoi giorni contati, gli ultimi scambi, le parole, gli sguardi e i gesti ancora possibili divengono l’unica risorsa per proseguire con dignità il tratto di vita che ancora rimane da vivere.
Si dimentica troppo spesso che una vita fortemente insidiata nella propria salute può arrivare a destare tutte le risorse insospettate che dormono nei sotterranei del proprio essere, tutte le ricchezze e la bellezza che non sono state ancora sfruttate, per- ché, nello stato di salute, ne sono state privilegiate altre. «Quale grande menzogna si nasconde dietro certe espressioni che insistono tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute!»: così si espresse Papa Francesco nel suo messaggio per la XXIII giornata mondiale del malato, nel 2015. È proprio per questo che, per coloro che si trovano a vivere nella propria esistenza certi mali, la cura della propria interiorità assume a un certo punto la medesima importanza delle cure mediche. In tal senso, un risanamento del proprio mondo interiore diviene sempre possibile, pur di fronte a un morbo incurabile. Spesso è proprio tale cammino di risanamento interiore a influire positivamente non solo sull’accettazione del decorso del proprio male, ma anche sulla risposta del paziente alla sollecitazione del- le cure. Il dolore, come si sa, fa abitualmente cadere tutte le maschere.
È proprio la fragilità che da questo deriva, assieme all’ineluttabilità del male che lo sta aggredendo, a favorire spesse volte nel paziente l’insorgere di nuove domande circa la propria vita, la propria esistenza, il proprio essere nel mondo, la morte e, parimenti, la necessità di una speranza, di un affidamento, di un anelito che vada al di là della contingenza di quanto nel presente è chiamato con sofferenza a vivere. Tutto questo contribuisce fortemente a far prendere consapevolezza da parte del malato della necessità di essere aiutato ad ascoltare la propria dimensione spirituale e a darle voce. Il dolore fisico, in- fatti, se non con la guarigione, con alcuni accorgimenti farmacologici può passare: mai, però, l’aver sofferto.
È proprio la stessa esperienza del soffrire a far nascostamente, ma realmente, prende- re consapevolezza a molti malati della necessità di iniziare ad abitare gli spazi spirituali della propria interiorità. Tutto questo, lentamente, aiuta anche a dirigere il dolore verso obiettivi concreti, dotandolo di senso. L’infragilirsi di un corpo in seguito alla presenza di una malattia grave o gravemente invalidante, oltre al senso di limite e di insicurezza, aumenta nel paziente anche il suo bisogno di dipendenza umana. La medicina contemporanea, figlia dello scientismo, è divenuta un sapere stretta- mente naturalistico-positivista che, pur avendo felicemente portato a pieno frutto il cammino della razionalità rispetto alla primeva comprensione medico-superstiziosa del male, ha inevitabilmente scisso la persona umana tra res extensa (il sòma) e res cogitans (l’anima) di cartesiana memoria. Sarà solo nel ribilanciamento della vasta acquisizione del sapere medico contemporaneo con l’attenzione al valore e al significato dell’esistenza umana che la cura del male potrà divenire anche cura della persona.