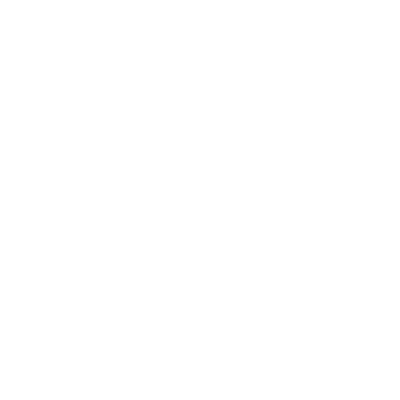di Luciana Mellone
Nell’imminenza della ricorrenza della giornata dei religiosi Camilliani Martiri della Carità, come ogni anno i nostri pensieri si rivolgono a chi, nei secoli scorsi, ha sacrificato la propria vita per curare ed assistere i malati anche colpiti da pestilenze: “etiam pestis incesserit”.
Mai come quest’anno l’attualità degli accadimenti, legati alla Pandemia del Coronavirus, ci catapulta in una situazione che forse tutti credevamo relegata nell’ambito dei ricordi e non del presente. Certamente anche se viene affrontata con strumenti diversi, la dedizione e l’impegno dei nuovi martiri del XXI secolo fa riemergere in noi ancora più forti le nostre emozioni, con la consapevolezza dei nostri limiti.
Corre l’obbligo onorare qui di seguito una parte di un numero considerevole di quei testimoni di carità, appartenuti all’Ordine dei Ministri degli infermi che nel corso delle pestilenze del XVII secolo, persero la propria vita. Pur consapevoli, avendo espressamente accettato il quarto voto specifico del loro Ordine, che nell’accudire gli appestati avrebbero quasi certamente contratto il morbo, si sono donati completamente con generosa dedizione, amore e competenza, dando un esempio di carità fuori del comune, tanto da meritarsi l’appellativo di martiri della carità.
La prima e non unica vittima della peste scoppiata a Palermo nel 1624, per un vascello senza quarantena e disinfestazione, fu il p. Giovanni Battista Pasquali[1], Così lo ricorda il p. Domenico de Martino, prefetto della casa camilliana di Palermo:
Religioso di molta virtù e carità, entrò con tanto fervore et spirito che era di stupore, a chi il mirava, essendo infaticabile …Giunto nelle case per amministrare i Sacramenti, et trovando tutti ammalati (dopo aver atteso) alle cose dell’anima, si rivolgeva ai bisogni del corpo, cioè a rifare i letti, appiccicare il fuoco, far da mangiare, e dopo cibato (gli infermi), lavare i piatti, spazzare la casa, cibare i figliolini, e far quanto quei meschini avevano di bisogno.[2]
Morirà a Palermo il 31 luglio 1624, “di peste, nel servizio degli appestati” [3]
L’Ordine dei Ministri degli Infermi fu messo ancor più duramente alla prova durante l’epidemia del 1630 che flagellò principalmente le città del nord: Mantova, Milano, Bologna, Ferrara, Firenze, Borgonovo, Mondovì e Occimiano dove erano presenti le loro comunità, espandendosi poi verso il centro Italia, Modena Lucca, Imola, e Roma.
I religiosi impegnati nell’assistenza agli appestati nonché allo spurgo e sanificazione della corrispondenza, delle cose e dei luoghi, furono circa centoventi, dei quali cinquantasei morirono per aver contratto il morbo.
Questa volta il contagio fece il suo ingresso nella penisola italiana attraverso le truppe francesi e imperiali nell’assedio di Mantova del 1629. La stessa città fu la prima a pagarne le gravissime conseguenze. Gli abitanti si ridussero da cinquantamila a settemila. Nella “cronaca universale della città di Mantova”, dello storico del settecento, Federico Amadei, si legge che: “spiccarono sopra tutti i Padri Ministri degli Infermi accorrendo dappertutto a porgere conforto a’ poveri moribondi”[4]. Lo stesso prefetto della comunità, p. Giovanni Coquerel[5] si dedicò con generosità e dedizione all’assistenza degli ammalati e moribondi nelle case private, trovando egli stesso la morte il 6 aprile del 1630. Stessa sorte toccò ad altri nove religiosi, tra cui si ricorda il p. Francesco Antonio Bucchiella[6]. Le corsie dell’ospedale erano in sovraffollamento e, nell’attesa che fosse aperto un lazzaretto, aveva accolto nella casa religiosa quanti più infermi possibile. Moriva il 16 aprile del 1630.
Milano pagò un caro prezzo in numero di vittime con 15 professi (due padri e tredici fratelli) e un aggregato (Alessandro Amadei).
Tra le figure più note si ricordano il camilliano milanese fr. Giulio Cesare Terzago[7] e il fr. Olimpio Nofri. Fr Terzago annunciò l’arrivo della peste a Milano già nell’autunno del 1629. Già capo infermiere negli ospedali di Napoli e di Genova aveva dato prova della sua capacità e competenza. Durante la peste di Palermo, si ammalò gravemente riuscendo però a vincere il male. Fu poi a Milano presso l’ospedale maggiore Ca’ Granda, dove contrasse ancora una volta il male e ancora una volta riuscì a superarlo; fu poi inviato presso il lazzaretto di S. Barnaba. Forte della sua esperienza, svolse energicamente e con grande perizia il gravoso compito, questa volta però il morbo non lo risparmiò e dopo poco morì in data incerta tra l’agosto e il settembre del 1630.
Un’altra grave perdita fu quella del fr. Olimpio Nofri[8], senese di origine che fin dal suo ingresso nell’ordine nel 1602, si dedicò sempre con grande competenza, 


Anni dopo il fr. Nofri, durante la peste di Milano, avrebbe preso il posto di fr. Terzago, trasferitosi al lazzaretto di Santa Barnaba, come capo infermiere alla Ca’ Granda. Si prodigò nel suo ufficio senza risparmiare le sue fatiche fisiche e spirituali, con quella carità che lo aveva sempre contraddistinto. Non appena ebbe le prime avvisaglie di essere stato colpito dal contagio, lasciò l’Ospedale, per non essere di pericolo agli altri, e si trasferì in una casa di campagna che i padri avevano avuto in dono da Mons. Besozzo e che inizialmente era servita loro come dimora quando non erano nell’Ospedale e che in questo frangente destinarono a rifugio dei confratelli contagiati dalla peste, denominandola per tal ragione – in seguito – la «Casa della morte». Qui attese la morte che sopraggiunse nell’agosto del 1630.
Fu a Bologna però che il morbo si accanì con tale violenza da fare una vera e propria strage tra la popolazione, solo nel centro urbano si contarono 13.398 vittime su 61.559 abitanti.
Anche in questo caso nella lotta contro l’epidemia furono protagonisti i camilliani incaricati di assistere gli appestati presso i lazzaretti e nelle case private, oltre al gravoso e pericoloso compito dello spurgo delle lettere e della sanificazione dei luoghi[9]. Lo stesso prefetto della comunità, p. Giovanni Battista Campana[10], fu chiamato a far parte dell’Assunteria di Sanità, commissione sanitaria cittadina, che aveva il compito di dare le direttive per contrastare il diffondersi dell’epidemia. Purtroppo però, come anche oggi accade, c’è sempre qualche voce fuori dal coro che contravvenendo alle disposizioni non fa altro che creare nuovi e gravi problemi. In questo caso, il senato della città, autorizzò la fiera c.d. del “pavaglione” che si teneva il 27 giugno e che, accompagnata da una solenne processione penitenziale, produsse il devastante effetto di maggiore diffusione del contagio, mandando in sofferenza i lazzaretti, con la conseguenza di accomunare gli appestati con i sospetti e i convalescenti, aumentando esponenzialmente il numero delle vittime.
La criticità della situazione richiese l’invio di nuovi religiosi da Roma incaricati di far eseguire le disposizioni dell’Assunteria Sanitaria, designati a presiedere ciascuno un quartiere della città in qualità di visitatori generali: p. Giovanni Battista Novati, p Giovanni Paolo Zazio, p. Ottavio Danieli ai quali si aggiunse il p. Francesco Prandi, bolognese. Si programmò un nuovo piano organizzativo per i servizi di assistenza sanitaria che portò all’apertura di nuovi lazzaretti in varie zone della città, questa volta suddivisi tra quelli che accoglievano gli infetti, quelli per gli uomini, per le donne, per i convalescenti e per i sospetti. Compito dei suddetti padri, oltre alla cura corporale e spirituale degli ammalati, era quella di dare un aggiornamento delle statistiche tra i morti, infetti e sospetti, facendo trascrivere i dati in appositi registri in modo da permettere il controllo dell’evoluzione del contagio. Per i sospetti veniva imposta una quarantena al termine della quale potevano uscire solo previa autorizzazione scritta dal visitatore del quartiere.
Il compito di presiedere alla disinfezione e disinfestazione delle case e delle robe infette o sospette di peste fu affidato al p. Zazio. Questi coordinava nello svolgimento di tale compito, 60 uomini, vestiti con un sacco


Sia il p. Campana che il p. Zazio furono al servizio degli appestati in altre città dell’Emilia Romagna. Entrambi a Modena diedero il loro prezioso contributo; il p. Zazio fu poi a Ferrara e ad Imola.
A Borgonuovo (Piacenza) perivano, tra gli appestati, altri quattro «Ministri degli Infermi», tra i quali il p. Marapodio[11]. Dopo aver pietosamente curati fino all’estremo delle sue forze gli appestati, colto egli stesso dal male, si trascinò ai piedi del Tabernacolo per esalarvi, nell’adorazione, l’ultimo respiro. “Esso buon padre, si fece communemente Servo di tutti, per onorare il Signore, poiché non vi era afflitto, ò moribondo, che dalle sue visite, e dalla sua pijssima mano, non ricevette soccorso”[12]
A Mondovì altri sette religiosi persero la vita: tra essi i Padri Pizzorno, Morelli e Lavagna.
A Firenze e a Lucca la strage fu meno sensibile, ma tuttavia richiese all’Ordine altre quattro gloriose vittime, tra le quali due particolarmente note: il p. Donato Antonio Bisogni, a Firenze, e il p. Domenico De Martino, a Lucca.
Alcuni anni dopo nel 1656-1657 la peste si riaffacciò, questa volta a Napoli portata dalle truppe dei soldati spagnoli provenienti dalla Sardegna e ancora una volta trovò i Ministri degli Infermi pronti a offrire la loro vita al servizio dei malati. Il morbo non ebbe pietà: . «Di soli Religiosi Sacerdoti, novantasei furono falciati dalla morte» sopra un centinaio ch’essi erano prima del contagio. Molti documenti andarono persi e ci restano così solo i nomi di 27 Padri, tra i quali Prospero Voltabio, Giovanni Battista Crescenzi, il provinciale di Roma, Luigi Franco, Troiano Positani.
Tra le prime vittime ci fu il servo di Dio fr. Piero Suardi[13]. Di famiglia nobile bergamasca era entrato nell’ordine nel 1616, dal 1620 si trovava ad operare presso l’ospedale dell’Annunziata, Il padre Regi dedica a lui un intero capitolo nelle sue “Memorie historiche…”:
Il nostro F Pietro Suardi, il quale, al vedere tanta grande moltitudine di Languenti, sicome ardeva di vera e perfetta Carità, verso di Dio, e de prossimi; così senza riposo veruno, intrepidamente attendeva, che con ogni più esatta cura, fussero serviti quei miseri infermi; laonde, con la domestichezza con la quale trattava, con i medesimi, né venne à contrahere il malore, perloche gli toccò la buona sorte di essere antesignano à tutti gl’altri poi de’ Nostri, che lo dovevano imitare nel spender la vita, per i Prossimi suoi.[14]
Morì il 01 aprile del 1656.
A Roma, intanto, nello stesso anno il papa Alessandro VII costituì una speciale “Congregazione della Sanità” tra le cui deliberazioni vi fu la creazione dello “spurgo delle lettere” in un villino fuori porta San Giovanni il compito gravoso e delicato affidato all’Ordine dei Camilliani, prevedeva che tutta la corrispondenza destinata alla Santa Sede e ai rappresentanti dei vari Stati, venisse trasmessa allo spurgo. Fu attrezzato anche un lazzaretto sull’isola Tiberina, a dirigere il quale fu chiamato, in seguito alla morte del cappuccino p. Alessio Messana, il camilliano fr. Angelo Cicarante. Con l’estendersi del contagio altri due spurghi furono aperti fuori porta Flaminia affidandone la soprintendenza sempre ai religiosi camilliani. In uno detto “immondo” veniva praticata la disinfezione vera e propria delle robe delle persone ricoverate al lazzaretto (effetti di lino, di canapa, di lana, di seta), l’altro detto “mondo” o “pulito” era riservato per gli ultimi lavaggi. Il contagio causò la morte di 15 mila persone su una popolazione di 120 mila abitanti, tra questi ci fu anche il generale dell’Ordine, p. Marcantonio Albiti che venne a mancare il giorno di Natale del 1656.
Nella primavera del 1657 il morbo riapparve ancora più virulento nella città di Genova, mietendo in poche settimane migliaia di vittime. Per il numero in rapida crescita dei contagiati, fu 


Naturalmente quelli proposti sono solo alcuni modelli esemplari di un lungo elenco di coloro che donarono la loro vita con generosità per il servizio agli appestati. Sono certa che molti sono a conoscenza delle vite di questi angeli camilliani, ma sono altrettanto certa che nessuno di noi avrebbe mai immaginato che queste toccanti pagine di storia di più di tre secoli fa risuonassero tragicamente attuali oggi, con lo scatenarsi di questo altrettanto temibile nemico chiamato Coronavirus o Covid 19. Gli attuali ospedali COVID 19 come I lazzaretti di ieri; nelle disposizioni sanitarie date dall’Assunteria Sanitaria possiamo ritrovare alcune delle disposizioni che oggi vengono suggerite dal comitato tecnico scientifico al governo: l’imposizione della quarantena ai sospetti contagiati e il divieto di uscire senza autorizzazione; la sanificazione dei luoghi e delle strade così come le operazioni di spurgo praticate dai padri camilliani, la richiesta di personale in aiuto o in sostituzione dei deceduti nell’esercizio del proprio dovere e tante altre similitudini potremmo trovare, ma soprattutto l’identica dedizione che i Ministri degli Infermi attuano nel servire i malati secondo i preziosi insegnamenti dello stesso padre Camillo: “Se alcuno, ispirato dal Signore Iddio, vorrà esercitare l’opre di misericordia, corporali et spirituali, secondo il Nostro Istituto, sappia che ha da esser morto a tutte le cose del mondo, cioè a parenti,amici, robbe, et a se stesso, et vivere solamente a Giesù Crocifisso sotto il suavissimo giogo della perpetua povertà, castità, obidienza et servigio delli poveri infermi ancorché fussero appestati, nei bisogni corporali et spirituali, di giorno et di notte […], il che farà per vero amor de Dio, et per far penitenza de suoi peccati; ricordandosi della Verità Christo Giesù”.[17]
Nella speranza che questa emergenza che stiamo vivendo passi presto, non ci resta che pregare e sostenere con coraggio l’ammirevole dedizione e impegno di questi nuovi angeli del XXI secolo, che insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario stanno lottando e rischiando la propria vita e, che in taluni casi hanno tragicamente perso la loro, per tutti noi.
[1] MOHR,41
[2] Sannazzaro Piero, Storia dell’Ordine Camilliano (1550-1699), Camilliane, Torino, 1986, 120
[3] AGMI 1520, f. 162 (17 ag. 1624). Negli atti di Consulta, diverrà la formula di rito per distinguere i morti nell’esercizio del ministero dagli altri morti occasionalmente di peste
[4] F. Amadei, Cronaca Universale della città di Mantova III, C.I.T.E.M.. Mantova 1956, 509-519
[5] MOHR, 215
[6] MOHR, 265
[7]Regi, 282-285; Mohr,233
[8] Mohr,238
[9]durante il loro servizio morirono il p. Pinocchi, il diacono Giuliano Guidetti e i fratelli Giovanni Battista Franchi e Andrea del Vecchio.
[10] Mohr,505
[11] Mohr,359
[12] Regi,286
[13] Mohr, 465
[14] Regi, p. 395
[15] Mohr, 439
[16] https://new.camilliani.org/fr-giacomo-giacopetti-un-grande-maestro-un-grande-discepolo/
[17] Bolla “Illius qui pro Gregis” di Gregorio XIV, 21 settembre 1591, art. 1