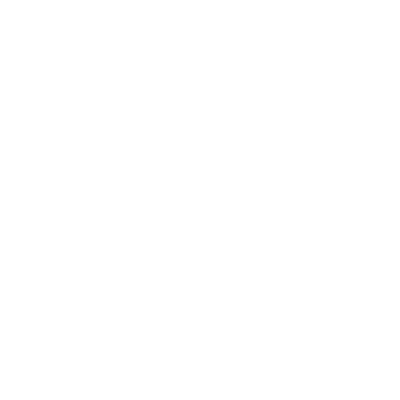di Gianfranco Lunardon
Una testimonianza di altri tempi: la storia ‘maestra’ di vita
«Renzo intanto trottava verso il quartiere del buon frate. Con un po’ di studio, e non senza dover rifare qualche pezzetto di strada, gli riuscì finalmente d’arrivarci. Trovò la capanna; lui non ce lo trovò; ma, ronzando e cercando nel contorno, lo vide in una baracca, che, piegato a terra, e quasi bocconi, stava confortando un moribondo. Si fermò lì, aspettando in silenzio. Poco dopo, lo vide chiuder gli occhi a quel poverino, poi mettersi in ginocchio, far orazione un momento, e alzarsi» (Alessandro Manzoni – I promessi sposi (1840) Cap. XXXVI).
È il 1630: a Milano infuria il flagello della peste che, solo nelle regioni del nord Italia, si ipotizza decimò circa un milione di persone.
Il ‘buon frate’, fra Cristoforo, era forse un camilliano? Potrebbe essere: il religioso che nei Promessi Sposi scoprì per primo la peste del 1630 potrebbe essere stato ispirato non tanto a un cappuccino, il con il saio bigio dei seguaci di Francesco d’Assisi bensì alla figura del camilliano fratel Giulio Cesare Terzago, con la sgargiante croce rossa che domina la talare dei figli di san Camillo de’ Lellis, che per l’appunto prestò servizio agli appestati in un lazzaretto milanese, fino a morire per lo stesso contagio. L’ipotesi è già stata documentata con una certa ampiezza nel 1930 in un libro di p. Mario Vanti su I camilliani, il Manzoni e la peste del 1630.
Si tratta appunto di fratel Terzago, nobile milanese non più giovanissimo (era nato infatti nel 1584 e si era fatto camilliano a vent’anni, accolto dal fondatore stesso) e capo-infermiere alla Ca’ Granda: l’Ospedale maggiore del capoluogo lombardo. All’epoca i «ministri degli infermi» seguaci di san Camillo facevano voto speciale di dedicarsi al «perenne servizio dei malati anche colpiti da peste»; difatti Terzago era stato a Palermo durante l’epidemia scoppiata nel capoluogo siciliano tra il 1624 e il 1626, distinguendosi per dedizione nella responsabilità di un lazzaretto: «Per poter attendere a tutti i bisogni con sollecitudine – racconta una cronaca dell’epoca – cavalcava un animaletto stando in volta continuamente di giorno e di notte, senza nessun risparmio; faceva infinite opere di carità… et spesso era visto pigliarsi le creature in braccio che languendo aspettavano la morte, gli faceva le minestre et l’imboccava».
Dopo quattro mesi, però, anche il religioso si era ammalato e venne inviato prima in quarantena, poi in convalescenza e infine nella sua patria milanese, dove i suoi confratelli lavoravano appunto all’Ospedale Maggiore.
L’epidemia raggiunse poi l’apice dalla primavera del 1630 in avanti, fino a dicembre; alla fine del morbo, dei 130 mila abitanti di Milano ne rimanevano in vita circa 60 mila. E i religiosi furono in prima fila nell’assistenza. I camilliani, in particolare, contavano la loro prima vittima già il 15 aprile e alla fine, su 50 religiosi impegnati in città, i deceduti saranno la metà. Si aprivano infatti anche altri lazzaretti, pare uno per ogni porta milanese, e dal luglio fratel Terzago – che aveva contratto la malattia alla Ca’ Granda ed era guarito – fu destinato con due confratelli al lazzaretto di San Barnaba presso Porta Ticinese, capace di circa 4.000 malati. Testimonia il confratello p. Vanti: «Per due mesi, quanti sopravvisse, egli fu là dentro l’angelo della vita e della buona morte»; fino a morire egli stesso, in una data incerta tra il 19 agosto e il 2 settembre 1630.
Cosa ci insegnano i martiri della carità?
Ai tempi ci fu un’autentica gara nella ‘carità’ tra religiosi, anche afferenti a carismi diversi; ci fu una concorde tensione in tutta la chiesa, uomini e donne, per contendersi la ‘pietanza grossa’ della carità, sotto l’unica bandiera della prossimità cristiana, ispirata dal comune Vangelo della misericordia: possiamo ricordare a mero titolo di esempio, la statura di santità di Luigi Gonzaga, giovane gesuita, di Carlo Borromeo, vescovo di Milano, di Caterina da Genova, di Francesco Maria da Camporosso, tutti santi e sante della peste, del colera, del tifo, …
Penso che i nostri ad altrui confratelli ‘consacrati’, che noi oggi ricordiamo e veneriamo come ‘martiri della carità’, in quei frangenti altamente drammatici della loro vita personale e comunitaria, non avessero intenzione di ‘insegnare’ niente a nessuno.
‘Insegnare’ presuppone una cattedra, un altare, dei contenuti codificati: questi uomini invece erano troppo impegnati a ‘vivere’; a vivere semplicemente al meglio la loro consacrazione – in alcuni casi la semplice e fondamentale consacrazione battesimale – in un contesto di prossimità con la malattia e con la morte che non lasciava nulla alla fantasia circa la loro sorte nel futuro immediato (e cioè il loro altamente probabile contagio e la morte a seguire!) e non lasciava troppo spazio e tempo al ragionamento o alla formulazione di piani strategici di intervento.
Certamente non erano uomini o donne né ingenui nei lori sentimenti spirituali e nella loro riflessione razionale, né approssimativi nel loro comportamenti pragmatici. Tuttavia, era la situazione contingente di bisogno, di dolore, di lutto che determinava l’immediatezza del loro comportamento e dettava lo stile molto umano ed empatico delle loro scelte. Le descrizioni vive che abbiamo della loro opera nel contesto pandemico dell’epoca non si prestano ad alcuna forma di interpretazione: ‘stabat’!
Stavano presso le persone afflitte, bisognose, malate: c’era una presenza intensa, un tocco pietoso, una parola consolante, una mano rassicurante, uno sguardo premuroso, del tempo lungo e dedicato; c’era una persona che, con una personalità corporativa, quasi a rappresentare tutta una comunità religiosa ed ecclesiale, sostava presso il malato.
Il ‘buon frate’ mette in sequenza una serie di azioni squisitamente umane che ripercorrono le stesse immediate e concrete scelte del buon samaritano del Vangelo: “in una baracca, piegato a terra, e quasi bocconi, stava confortando un moribondo. … lo vide chiuder gli occhi a quel poverino, poi mettersi in ginocchio, far orazione un momento, e alzarsi”.
Quello che fa maggiormente impressione è il loro vivere in modo così naturale, senza mediazioni categoriali o riduzionismi interpretativi, il rovesciamento stesso che Gesù chiede al dottore della legge: da «Chi è mio prossimo?» (Lc 10,29) a «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» (Lc 10,36). Il focus che catalizza ogni intervento non è più ‘il mio’ ma ‘chi è caduto nelle mani dei briganti’; il baricentro dell’opera di intervento non sono più i ‘miei’ sentimenti, propositi, paure, aspirazioni, ma i ‘suoi’ bisogni, paure, necessità, tormenti, sofferenze!
Personalmente, l’ammirazione e lo stupore quasi increduli verso l’audacia ed il coraggio delle opere di questi uomini si mischia con l’inquietudine di alcune semplici domande che mi perseguitano da diverso tempo. Infatti se è emotivamente molto bello sfogliare queste meravigliose pagine del nostro ‘album di famiglia’ (chiesa, comunità ecclesiali, istituti religiosi, …) per scoprirci orgogliosamente eredi e membra di una così imponente storia umana e cristiana, credo sia ancora più importante leggere tra le righe di queste biografie individuali per cogliere alcune coordinate che mi possono, oggi, realisticamente istruire e convertire.
Gratia supponit naturam et perficit eam. Che natura poteva avere il ‘buon frate’, che la grazia poi ha performato fino al punto di renderlo capace di un gesto così naturale come il ‘chiudere pietosamente gli occhi ad un appestato appena morto’?
L’uomo, ogni uomo, compreso tra le vette della santità e l’abiezione del peccato, non è mai frutto del caso, del determinismo, ma sempre di un intreccio di relazioni che lo qualificano o lo squalificano, ossia che danno o tolgono consistenza alle sue qualità naturali.
In quali famiglie sono nate e cresciute queste persone? In quali comunità cristiane sono state ‘iniziate’ alla fede e alla carità? Quali coordinate culturali e spirituali hanno nutrito e orientato la loro immagine di Dio e dell’uomo? Che tipo di formazione o quali formatori hanno fatto discernimento sulla loro vocazione e poi l’hanno coltivata e fatta crescere? Con chi si sono accompagnati e sostenuti e confrontati in queste scelte di vite? Quali uomini li hanno aiutati a diventare persone pienamente umane?




La profondità del pensiero e della vita spirituale
Stiamo vivendo un periodo particolare dove le ombre sembrano occupare quasi tutto lo spazio della luce, le risorse esaurirsi, le fragilità e le paure guidano il timone della nostra esistenza e della storia. Molti di noi si ribellano, altri subiscono o reagiscono, altri ancora costruiscono anche pagando di persona, perché l’altro viva.
Spesso crediamo di poter risolvere ogni situazione precaria sbandierando e difendendo in tutti i momenti il nostro pensiero, anche se non è sempre fondato sul Vangelo o confrontato con altri per trovare una sintesi in ogni frangente. In realtà, se osserviamo la storia individuale e sociale, ci rendiamo conto che vi è “molto movimento alla superficie della mente, però non si muove né si commuove la profondità del pensiero” (Gaudete et Exsultate 38). Assolutizziamo, talvolta, il pensiero individuale senza, però, tradurlo in azione.
Presi dalla morsa del nostro individualismo, non vediamo, né ascoltiamo neanche chi vuole camminare con noi, per poter rivisitare insieme i percorsi e cercare una lettura obiettiva di ogni spaccato di vita. Metodo comune adottato oggi: qualsiasi offerta che proviene dall’altro è da contestare, senza verificare se il contributo può aprire nuovi processi che “costruiscano un popolo, più che ottenere risultati immediati che producano una rendita di immagine facile, rapida ed effimera, ma che non costruiscono la pienezza umana” (Evangelii Gaudium 224). In difesa del nostro orticello, sembra che ci manchi la capacità di allargare la visione globale sul mondo, per vedere il positivo nell’altro e riconoscere il pezzo a cui agganciarsi, per costruire il bene comune.
Come è difficile oggi mettere insieme le varie tessere del puzzle che restituiscano una visione globale della realtà attraverso l’esercizio continuo di una profondità di pensiero!
Abbiamo bisogno di ritornare ad essere persone umane, abbiamo bisogno di riscoprire la cura del bene comune, abbiamo bisogno di un approccio di fede con la realtà. Forse è passato di moda l’impegno ad essere santi come Dio è santo? Che cosa significa per noi oggi seguire la via della santità, per essere testimoni autentici di Gesù Cristo?
Oggi è urgente ritrovare il Signore, il senso della nostra vita. Coltivando la relazione con Lui, possiamo ascoltare la sua Parola e viverla nella quotidianità non nelle grandi occasioni, ma nell’attimo presente, portando il nostro contributo evangelico che prende forma nelle scelte non solo personali ma anche sociali. Non possiamo continuare a rimanere spettatori della storia.
La santità di una vita si rivela nella capacità della persona di esserci sempre evangelicamente laddove vive, per costruire una società dell’amore, dove testimonia che l’altro è prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali e che l’amore per lui spinge a cercare il meglio per la sua vita (cfr. Fratelli tutti 94).
Lo spessore della vita cristiana e, quindi, del cammino di santità del credente si riconosce subito dall’amore che ha verso Dio e verso i fratelli e verso le sorelle, senza esclusione. In questo tempo di pandemia in cui, per paura, rischiamo di chiuderci in un circolo egoistico, respingendo le persone, siamo chiamati a verificare la nostra capacità relazionale che ci fa essere dono verso gli altri, anche in tempi critici, come Gesù che ha dato la vita fino alla morte di croce.
Oggi, poiché non si parla facilmente della propria vita di fede, perché relegata spesso in una zona intimistica, c’è l’urgenza di condividere la ricerca del volto di Dio, di comunicare e di accogliere la modalità per rimanere sempre in relazione con gli altri, di cercare insieme le risorse attinte dal Vangelo per perdonare, per essere misericordiosi, per esprimere la tenerezza come amore preveniente, profondo verso gli altri, per essere uomini e donne di pace, di giustizia, di gioia, di speranza.
Non una santità aleatoria, quindi, ma una santità fatta di carne, che si vede in itinere, guardando l’esempio di Gesù, che si è incarnato ed è morto per noi, per vivere in pienezza da figli di Dio la bellezza della vita umana.




La maturazione in umanità
In questo tempo di pandemia siamo tutti chiamati a confrontarci e, in certo modo, a riconciliarci profondamente con la nostra umanità. Perlopiù, almeno nella nostra sensibilità e cultura occidentale, quando facciamo ricorso a questa parola ‘umanità’, siamo soliti farlo in modo assai solenne e talvolta presuntuoso. Evochiamo questa preziosa parola, in cui ci riconosciamo, per distinguerci dalle altre creature viventi, nel senso di una eccellenza che diamo per scontata e per acquisita. In realtà, questa parola rimanda radicalmente a quell’humus, a quella terra argillosa da cui siamo stati tratti e verso cui siamo chiamati a ritornare con serenità, dopo aver percorso il nostro cammino di umanità.
La caratteristica più propria della nostra dignità umana è la consapevolezza della nostra realtà che dovrebbe generare sempre l’humilitas. L’umiltà è propria delle persone umane degne di questo nome. Nella nostra cultura occidentale siamo più inclini a pensare alla nostra umanità a partire dal mito di Prometeo che non dal mistero di Cristo Signore.
L’esperienza così difficile di dover far fronte ad una pandemia come quella del Coronavirus si sta rivelando uno choc quasi assordante: non pensavamo di essere anche noi vulnerabili e così tremendamente fragili. Ci eravamo convinti di essere una porzione dell’umanità che, a costo di sacrifici e di intraprendenza mirabili, si era guadagnata il privilegio di una sostanziale e durevole immunità dalla paura e dal senso così umano di insicurezza. Eravamo così fieri e pieni di noi stessi da arrivare a pensare persino che gli altri – i popoli più poveri e svantaggiati – in realtà raccoglievano il frutto della loro pusillanimità tanto da sentirci in dovere di negare loro il diritto a sedere al banchetto della nostra felicità.
La pandemia ha cambiato tutto in un attimo. Il rallentamento del nostro ritmo consueto può essere un’occasione per guadagnare in profondità e per amplificare la nostra modalità di vivere le realtà cosi ampie e variegate della nostra vita. La sfida di passare dal galoppo delle emozioni e delle sensazioni alla pacata degustazione di ogni frammento di vita, anche quando è limitato dalla costrizione della situazione, diventa un compito per crescere in umanità. Il senso chiaro di fragilità può diventare l’occasione per cogliere l’essenziale e tenersi pronti a tutto, anche a ciò che ci sconvolge.
La paura dovrebbe indurci a riflettere sulla precarietà della salute e della vita, sulla provvisorietà delle certezze e dei beni acquisiti, sulla realtà o possibilità della mortalità propria o delle persone care o degli altri. Fare introspezione è un’occasione salutare: il virus fornisce un bagno di realismo esistenziale. Dobbiamo scegliere di guadagnare in profondità. È questo l’unico modo per raggiungere le periferie talora così poco frequentate della nostra personalità, perché tutto sia più luminoso e sereno. Abbiamo l’occasione di ritrovare quell’armonia di cui portiamo nel cuore non solo l’insopprimibile nostalgia, ma pure l’alfabeto necessario per narrarla e trasmetterla soprattutto nei momenti più difficili e gravi.
La comunità dei discepoli di Cristo non rinuncia a vivere meglio il messaggio del Vangelo e a testimoniarlo al mondo. La pandemia mette in crisi quel modo di supponenza che si traduce in dimenticanza della nostra fragilità fino a nascondere la morte. Come discepoli del Signore Gesù crediamo nella risurrezione e, in forza di questa nostra fede, attendiamo la vita eterna senza confonderla mai con la pretesa e l’illusione di essere immortali. Come creature siamo mortali e la morte, unitamente alle tante morti che dobbiamo attraversare nella vita, è parte integrante della nostra umana avventura.
In una situazione che ci rende consapevoli di essere tutti potenzialmente malati, l’annuncio della speranza cristiana si fa ancora più urgente e forse persino più udibile dai nostri fratelli e sorelle in umanità. L’improvviso irrompere della morte sulla scena ha riaperto la grande questione del senso. La condizione attuale ci mette a confronto con uno dei grandi tabù della cultura contemporanea, la morte. La morte è stata “esculturata” dalla società contemporanea.
Oggi è tornata, in maniera improvvisa e in modalità sconosciuta. E non c’è dubbio che è una occasione per svegliare le nostre coscienze intorpidite da un benessere egocentrico, narcisista. La morte per malattie polmonari, negli anni passati, era molto presente ma non ci ha mai scandalizzato. Le morti per incidenti stradali sono innumerevoli, ma non ci sconvolgono. E così oltre. Questa volta, un piccolissimo e sconosciuto virus ha fatto emergere la paura della morte in tutti. E per di più ha sconvolto gli animi il fatto di morire senza nessuno accanto, senza il conforto dei sacramenti per chi crede, senza il funerale e neppure il posto nei cimiteri. Come non riflettere su questo?
Mai come oggi la relazione di cura si presenta come il paradigma fondamentale della nostra umana convivenza. Il mutamento dell’interdipendenza di fatto in solidarietà voluta non è una trasformazione automatica.
Questa condizione è un altro versante della fragilità rivelata dalla pandemia…
È una dimensione che ci pone, in maniera molto più netta e più nitida, il tema dell’oltre. Un tema universale, da sempre, e presente in tutte le culture. La morte ci porta sulla “soglia del mistero”. Lo spazio di questa soglia accomuna credenti e non credenti. Gli unici che si tirano fuori sono i non-pensati. Questa pandemia è un invito pressante ad alzare lo sguardo da un narcisismo avvilente.
L’opportunità di crescere c’è, perché la domanda sulla morte è stata sepolta dal narcisismo non è stata cancellata. Quello che stiamo vivendo in questo periodo è un’occasione per fare il punto sulla nostra maturazione in umanità. Essere umani, senza accontentarsi di far parte della categoria degli esseri umani che abitano questo lembo di cosmo con e tra le altre creature. Ciò che siamo costretti a vivere in questi giorni ci ricorda il dovere di accettare il nostro limite fino ad onorare quelli che sono i nostri limiti e portarli insieme. Ancora una volta possiamo fare nostro l’invito che rivolgeva a sé stessa Etty Hillesum: «Ma sopportiamolo con grazia», con umiltà, con pazienza e compassione.
La sofferenza non lascia mai uguali a sé stessi: o ci rende migliori o ci rende peggiori. La morte di alcuni, la sofferenza di tanti e la paura di tutti sono un segno che ci richiama ad un sussulto di dignità: siamo tutti malati di umanità! E qui la preghiera – nel senso più ampio e variegato – è un’àncora sicura: rivolgendoci all’Altissimo, come creature tra creature, ritroviamo la nostra giusta dimensione. Così potremo maturare la capacità di assumere persino la morte senza smettere di amare la vita e di lottare, appassionatamente, perché tutti l’abbiano in abbondanza.
Una domanda rimane in sospeso: come credenti sapremo distinguere l’illusione dell’immortalità dal desiderio della vita eterna verso cui ci volgiamo serenamente mettendo in conto la morte nostra e delle persone che amiamo?




‘Eroi’? No, solo ‘fratelli’!
Il poeta e drammaturgo tedesco Bertolt Brecht un giorno disse: “Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi”. In questi tempi di pandemia, spesso la retorica comune ha enfaticamente definito ‘eroi’, i sanitari o i fornitori di servizi essenziali alla collettività, salvo poi dimenticare, molto rapidamente, tutti i loro sforzi, o non sostenendoli con atteggiamenti condivisi, di prudenza, di impegno e di senso civico.
L’eroe sembra essere quell’uomo che con abnegazione assume un valore e con coraggio cerca coerentemente di viverlo. In questo senso la persona eroica sembra rivelare il volto ‘pieno’ della storia e contemporaneamente ne mostra anche tutti i ‘vuoti’ di virtù e le criticità dei progetti. A questo punto, se un popolo ha bisogno di identificare degli eroi vuol dire che gli aspetti deboli e fragili della storia contemporanea superano disperatamente gli aspetti valoriali e di senso. E come tale questo popolo vive una profonda e disperata ‘infelicità storica’!
Un popolo che non ha bisogno di ‘eroi’ è un popolo che non ha bisogno di azioni straordinarie per sentirsi vivo; non ha bisogno di miti eroici a cui delegare la sua identità; non ha bisogno di protagonismi per cogliere le sfumature del bene e della verità. Se il bene, la prossimità, la virtù, l’impegno, la coerenza, il sacrificio, la dedizione, il desiderio di trascendenza, la relazione di cura… fossero valori ed atteggiamenti propri solo di una parte elitaria ed eroica della società allora questi valori sarebbero delle utopie di pochi e la maggior parte delle persone sarebbe destinata alla noia e alla ripetizione di vuoti cliché!
La peste manzoniana del 1630 causata dal bacillo Yersinia pestis non è neppur paragonabile al Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), che conosciamo familiarmente come Covid-19, se non in senso molto traslato. La situazione sociale, l’evoluzione epidemiologica e le risorse sanitarie disponibili nella prima metà del 600 non sono minimamente raffrontabili con la nostra capacità e disponibilità tecnico-scientifica nel 2020.
Tuttavia una cosa non è cambiata dal 1630 ad oggi: la misura dell’umanità si misura nel rapporto con la sofferenza dell’uomo e soprattutto con il volto dei sofferenti. Come tale il paradigma umano che dobbiamo coltivare come singoli e come comunità non è quello dell’eroicità ma quello della fraternità!
La fraternità è la grande promessa mancata della nostra modernità. Ciò nonostante, anche da un punto di vista delle scienze umane, in tutta la loro articolazione, questa promessa mancata è ciò che rende possibile la libertà e l’uguaglianza. Dire “fraternità” non significa, però, dire qualcosa di scontato. “Fraternità” non è una parola vuota. “Fraternità” richiede una grande battaglia, innanzitutto contro il proprio individualismo, contro l’idolatria di se stessi. È la battaglia più difficile da combattere e da vincere. L’individualismo è il virus compagno del Coronavirus. L’individualismo è la grande eresia della modernità.
I martiri della carità, in questo senso, continuano ancora oggi a far germogliare sogni, a suscitare profezie e visioni a stimolare fiducia, a fasciare ferite, ad intrecciare relazioni e a creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani, e ispiri a tutti, non solo ad alcuni ‘eroi’, la visione di un futuro degno dell’uomo, in cui ‘i diritti dei deboli non sono diritti deboli’, non sono diritti tutelati dall’alto, ma riconosciuti e condivisi da una rinnovata coscienza comune.
Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti: la storia ci insegna che non ci sono sistemi né crisi in grado di annullare completamente la capacità, l’ingegno e la creatività che Dio non cessa di suscitare nei cuori.
I martiri della carità allora come oggi non hanno avuto timore di coinvolgersi e di toccare il corpo e l’anima dei loro contemporanei con lo sguardo di Gesù; non hanno avuto paura di abitare coraggiosamente i conflitti e i crocevia della storia per ungerli con l’aroma delle ‘beatitudini’; non hanno avuto paura di unirsi con altri uomini, per creare una vera comunità, per tessere un nuovo modo di fare la storia e di stare al mondo!