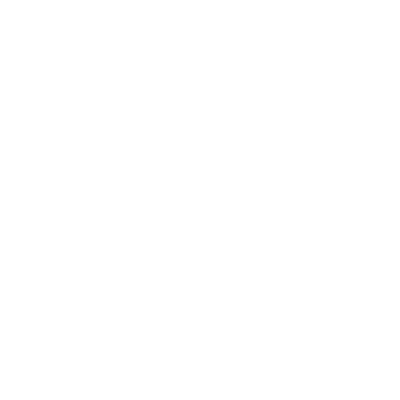di fr. Luca Perletti
L’Hospice ambisce a fornire al paziente e al suo nucleo familiare le condizioni per vivere anche quando la malattia sembra avere il controllo della situazione e, apparentemente, rimane poco tempo da vivere. Non avendo come proprio obiettivo di allungare la vita, ma di rendere più sopportabile e ricco di senso il tempo, l’Hospice è fedele al suo mandato quando accompagna il paziente nel processo di accettazione dell’ineluttabile destino; nella riconciliazione con il suo passato e nel commiato dai propri cari. Sembra una prospettiva da soap opera, di cui si ha traccia solo nel grande schermo; la realtà appare più cruda, segnata dalla fatica e dalla sofferenza nonché – spesso – dal desiderio di porre velocemente fine a dolori e limitazioni insopportabili.
Per quanto difficile e talvolta frustrante, assicurare qualità di vita fino all’ultimo istante è il fine dell’Hospice! Oltre il buon cuore e la solidarietà umana, questo dovere deriva all’Hospice dall’essere inquadrato tra i servizi del Sistema Sanitario i cui standard sono ripetutamente ribaditi da Documenti del Ministero della Salute[1]. Nel determinare l’appropriatezza del ricovero in Hospice, questi testi fanno riferimento non solo alla situazione sanitaria – ovvia e imprescindibile – ma anche al complesso di bisogni sperimentati dal paziente in fase terminale e dalla sua famiglia. In altre parole, un ricovero in Hospice è congruo quando ha in vista i bisogni della sfera psicologica, spirituale e socio-economica del paziente e del suo mondo relazionale. Un esempio della attenzione del legislatore a queste dimensioni lo troviamo nella determinazione, tra gli standard assistenziali minimi, della durata della degenza. Perché la cura palliativa residenziale possa raggiungere i propri obiettivi, il ricovero non dovrebbe essere inferiore ai sette giorni né superiore ai trenta. Infatti, una degenza inferiore ai sette giorni è troppo breve per permettere la presa di coscienza della propria prossima fine; oltre trenta giorni, si corre il rischio che l’inappropriata prognosi abbia impedito al malato di poter vivere a casa propria giornate piene di significato e di senso, trasformando l’Hospice in un reparto di terapia a bassa intensità, se non addirittura di riabilitazione, favorendo o rinfocolando speranze mai sopite.
 Tuttavia è ancora molto duro il cammino di consapevolezza sulle Cure palliative e sull’Hospice. Se ne ha un riscontro nei colloqui con i malati ed i loro familiari laddove emergono con chiarezza i molti miti, i preconcetti persino i pregiudizi sull’Hospice, miti che fanno fatica a morire. Tra i più comuni, la percezione che l’Hospice sia un luogo triste, tetro e buio, luogo della disperazione e della tristezza. Considerato come una sorta di “ultima spiaggia”, la sua esistenza è negata con un altro atteggiamento molto diffuso, la “congiura del silenzio”, di cui si fanno complici parenti e operatori, quasi che lo scoprire di trovarsi in Hospice apportasse danno alla salute del malato. Un silenzio che si esprime in risposte incomplete, in frasi interrotte, in improvvisa sordità. Il giovane Oscar, malato di tumore e protagonista di una favola, così lo esprime: “se dici ‘morire’ in un ospedale, nessuno sente. Puoi stare sicuro che ci sarà un vuoto d’aria e che si parlerà d’altro. Ho fatto la prova con tutti. Tranne con Nonna Rosa”[2]. I preconcetti, il silenzio e la resistenza a dare spazio alle paure del paziente si oppongono tenacemente agli sforzi degli operatori dell’Hospice nel conseguimento dei loro obiettivi!
Tuttavia è ancora molto duro il cammino di consapevolezza sulle Cure palliative e sull’Hospice. Se ne ha un riscontro nei colloqui con i malati ed i loro familiari laddove emergono con chiarezza i molti miti, i preconcetti persino i pregiudizi sull’Hospice, miti che fanno fatica a morire. Tra i più comuni, la percezione che l’Hospice sia un luogo triste, tetro e buio, luogo della disperazione e della tristezza. Considerato come una sorta di “ultima spiaggia”, la sua esistenza è negata con un altro atteggiamento molto diffuso, la “congiura del silenzio”, di cui si fanno complici parenti e operatori, quasi che lo scoprire di trovarsi in Hospice apportasse danno alla salute del malato. Un silenzio che si esprime in risposte incomplete, in frasi interrotte, in improvvisa sordità. Il giovane Oscar, malato di tumore e protagonista di una favola, così lo esprime: “se dici ‘morire’ in un ospedale, nessuno sente. Puoi stare sicuro che ci sarà un vuoto d’aria e che si parlerà d’altro. Ho fatto la prova con tutti. Tranne con Nonna Rosa”[2]. I preconcetti, il silenzio e la resistenza a dare spazio alle paure del paziente si oppongono tenacemente agli sforzi degli operatori dell’Hospice nel conseguimento dei loro obiettivi!
Il processo di accettazione che nell’Hospice ci sia ancora spazio di vita passa necessariamente attraverso l’umanizzazione degli atti che in esso vi si svolgono. Oltre la professionalità e la competenza, l’attenzione e la dedizione, l’accuratezza e la tempestività, l’Hospice realizza in pieno la sua natura quando l’uomo è messo al centro ed ogni azione – anche quelle squisitamente tecniche – hanno di mira il recupero della sua umanità, se non tutta almeno quella che gli è conservata. Anche quando potesse costare il sacrificio del regolamento a favore della risoluzione dei bisogni del malato. Nella favola già citata, l’infermiera di turno scopre che il giovane Oscar ha passato la notte con Peggy Blue, condividendo le reciproche vite. La caposala e l’infermiera – scoperti i due – iniziano a urlare, offese per l’infrazione delle regole. Solo l’intervento di Nonna Rosa mette fine al trambusto con una domanda provocatoria: “dovete soddisfare i pazienti o attenervi al regolamento?”[3]. È una domanda sempre valida per chi si occupa di Cure Palliative in regime residenziale. Il processo di umanizzazione della cura si gioca nella capacità dell’istituzione di essere flessibile, di offrire servizi a misura del bisogno, di facilitare la creatività, di stimolare la partecipazione di tutti, senza gradi di superiorità né gerarchie. Tale processo da’ spazio alle molte domande del paziente e lo mette al centro dell’attenzione facendolo così sentire protagonista della sua vita e del suo destino, ancorché questo avvenga tra le costrizioni imposte dalla natura ferita dalla malattia.
[1] Si vedano per esempio Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali, 2007; Standard relativi alle cure palliative, 22 febbraio 2007;
[2] Oscar e la Dama in Rosa, E. E. Schmitt, BUR Rizzoli contemporanea, 2014
[3] Ibidem