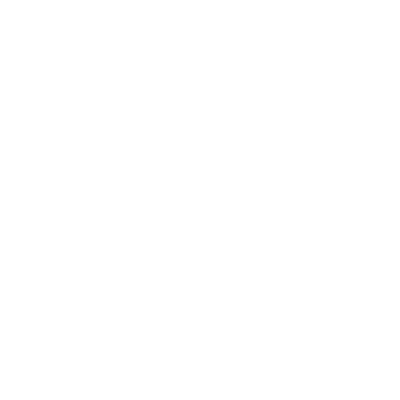Di p.Gianfranco Lunardon
«La comunione d’amore tra Dio e gli uomini trova una significativa espressione nell’alleanza sponsale, che si instaura tra l’uomo e la donna. L’amore sempre fedele di Dio si pone come esemplare delle relazioni di amore fedele che devono esistere tra gli sposi. La comunione familiare può essere conservata e perfezionata solo con grande spirito di sacrificio. Esige, infatti una pronta e generosa disponibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione» (Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio).
 La biografia e la personalità della Serva di Dio Maria Aristea Ceccarelli sono ben inquadrate dalla meditazione che Giovanni Paolo II propone sulla comunione familiare. L’esistenza di questa donna è stata una permanente sfida luminosa lanciata in un mondo circostante segnato da umano cinismo, un ponte teso tra due rive molto diverse: vita impastata di quotidianità tra le mura domestiche tra gioia e dolore, umiliazione ed accoglienza; perseveranza nella fede e nella preghiera anche se circondata da violenza, bestemmia e brutalità; dedizione semplice ed empatica al servizio dei malati pur nella chiara consapevolezza dei propri limiti e fragilità; esperienza personale di grandi sofferenze fisiche accolte con pazienza e speranza pur nella quasi totale incomprensione di coloro che la circondavano.
La biografia e la personalità della Serva di Dio Maria Aristea Ceccarelli sono ben inquadrate dalla meditazione che Giovanni Paolo II propone sulla comunione familiare. L’esistenza di questa donna è stata una permanente sfida luminosa lanciata in un mondo circostante segnato da umano cinismo, un ponte teso tra due rive molto diverse: vita impastata di quotidianità tra le mura domestiche tra gioia e dolore, umiliazione ed accoglienza; perseveranza nella fede e nella preghiera anche se circondata da violenza, bestemmia e brutalità; dedizione semplice ed empatica al servizio dei malati pur nella chiara consapevolezza dei propri limiti e fragilità; esperienza personale di grandi sofferenze fisiche accolte con pazienza e speranza pur nella quasi totale incomprensione di coloro che la circondavano.
Questa piccola lampada, pur ardendo in un mondo in cui si coltivavano solo i sentimenti più degradanti, ha continuato sapientemente ad ardere: il suo sorriso materno – lei che madre non lo è mai stata – non si è mai eclissato, non ha mai ceduto alla malinconia o alla rassegnazione, anzi ha continuato a rilanciare germi di disponibilità, di perdono, di confidenza per rendere più dignitosa anche la vita di chi la maltrattava. La sua fedeltà alla terra e all’humanum, coincide con la fedeltà a Dio e a quella porzione di dolore che la storia continuamente le assegna.
Modernamente, parlando di Maria Aristea, si potrebbe ricorrere al concetto di resilienza, termine derivato dalla scienza dei materiali, riguardante la proprietà che alcune sostanze hanno di conservare la propria struttura o di riacquistare la forma originaria dopo essere state sottoposte a schiacciamento o deformazione.
Applicata alle situazioni delle persone, la resilienza connota proprio la loro capacità di far fronte agli eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà. Non è quindi solo titanica capacità di resistere o stoica atarassia agli eventi negativi, ma essenzialmente capacità di ricostruire la propria dimensione, il proprio percorso di vita, trovando una nuova chiave di lettura di sé, degli altri e del mondo, scoprendo una nuova forza per superare le avversità.
Maria Aristea è stata saggiata come oro nel crogiuolo (Sap. 3,6): passando deliberatamente attraverso il fuoco, si è lasciata purificare. Non ha avuto paura della fragilità: né della sua né di quella altrui. Ha saputo entrare nella fragilità e nella sofferenza, in punta di piedi, considerandola – come Mosè al cospetto del divino (Es 3,5) – terra sacra, per sostenere ed accompagnare il controllo, l’impegno, l’autostima, le emozioni positive.
Contemplare la statura umana e spirituale di Maria Aristea è un po’ come contemplare l’immagine del povero Cristo silenzioso della Leggenda del Grande Inquisitore di Dostoevskij. Il Cristo che tace fa del proprio silenzio il rimedio alla parola idolatricamente vuota del Grande Inquisitore, contestandone con ciò la pseudo-verità e aprendo, nello stesso tempo, la possibilità di una parola diversa che giunge quasi dall’estremità più riposta del silenzio. Rivelando con ciò stesso l’essenza stessa della presenza divina nella storia. Il silenzio di Cristo – al pari della modesta esistenza di Maria Aristea – culmina in un gesto di donazione, il bacio, che brucerà per sempre l’Inquisitore, che brucerà più di ogni parola, e che è il definitivo modo con cui il Cristo gli sarà presente, fin nel deserto della solitudine. Questo gesto spiega come sia possibile che dalla fragilità, dalla sofferenza, dal silenzio nasca una parola che diventa realmente com-passione e testimonianza di prossimità che apre contestualmente alla speranza.
Solo nell’esperienza si può arrivare alla verità della vita, non stando “di fuori”, non nella retorica e nei bei discorsi, non nella dottrina disincarnata. “Il dolore è così grande che tratteggiarlo con la parola diviene insopportabile. Il dolore non ha volto, non ha nome certo, non seve a niente, e, tuttavia, voi vedrete che il dolore è più tangibile di tanti volti, è più sicuro degli amici, è più fecondo dei nostri lavori! … Lasciategli aperta non soltanto la porta del ricordo, ma anche quella della presenza e della speranza … Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca dalla carne. Questa sera ho la consapevolezza che non difendo una posizione…” (E. Mounier, Lettere sul dolore). Nel contempo, però, “non resta che una cosa: pregare, perché le tenebre non si confondano con la luce” (idem).
Maria Aristea continua ad essere sana provocazione perché ognuno di noi sia una vigile sentinella che non si rassegna a confondere le tenebre con la luce!
- Gianfranco Lunardon