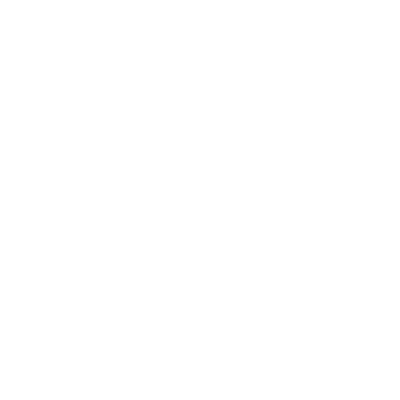di Arnaldo Pangrazzi, m.i.
Immersi nel mistero
 “La vita, scrive Paul Claudel, è una grande avventura verso la luce”.
“La vita, scrive Paul Claudel, è una grande avventura verso la luce”.
La fede cristiana si fonda su Cristo che ha vissuto l’evento drammatico della morte e l’evento prodigioso della Risurrezione.
A testimonianza dell’evento Pasquale c’è una tomba vuota, le apparizioni di Gesù risorto, le attestazioni degli apostoli: “Voi avete ucciso l’autore della vita, ma Dio lo ha risuscitato dai morti e noi ne siamo testimoni” (At 2,24).
La speranza cristiana, come recita il prefazio pasquale, si basa sulla certezza che “in Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge”.
Nel riflettere sulle realtà eterne l’uomo è condizionato dall’esperienza del corpo e delle categorie mentali, per cui risulta difficile comprendere la differenza tra il corpo biologico e il corpo che sarà trasfigurato.
Ora siamo figli del tempo e dello spazio, ma un giorno inizieremo un viaggio senza confini, dal tempo all’eternità.
Nelle parole di san Paolo: “Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo, nei cieli” (2 Cor 5,1).
Come è inconcepibile prefigurare una quercia contemplando una ghianda, come un bimbo custodito nel grembo della madre non può anticipare il suo domani, come tutta l’esistenza è un immenso mistero che si scopre man mano che lo si vive, così un giorno si godrà quella beatitudine che sulla terra si può solo parzialmente anticipare.
L’aldilà rappresenta il più grande enigma che agita la mente umana fin dagli albori della storia, dalla Persia all’Egitto, dalla Grecia all’epoca Romana, dalla civiltà Etrusca ai nostri tempi.
Da sempre, l’uomo non solo ricorda le sue radici passate, ma si interroga sul suo futuro destino, su cosa accadrà quando muore.
Questi quesiti e questa ricerca sono particolarmente sentiti da chi ha perso un/a figlio/a e si domanda su com’è o cosa accade nell’aldilà.
La fede nella risurrezione non toglie il dolore che inevitabilmente si sperimenta per la morte del proprio caro, ma aiuta a contemplare l’evento della mortalità nella prospettiva dell’immortalità futura, nella fiduciosa speranza che si realizzerà un giorno la piena comunione con Dio e con le persone amate.
La centralità del mistero di Cristo morto e risorto informa il cristiano che l’ultima parola non appartiene alla croce, ma alla vita donataci dal Risorto: “Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede” (1 Cor 15,17).


Nella catechesi sul mistero della morte, la Chiesa non si fissa in modo ossessivo sulla dimensione fisica, non favorisce un culto esagerato delle salme, non assolutizza il valore del cimitero, ma invita i credenti a riflettere sulla precarietà della vita, sulla provvisorietà dei beni terreni e a rivestirsi dell’uomo nuovo praticando le opere di carità, perché il futuro destino dipende da cosa si è fatto con la propria vita.
Molti, come Tommaso nel vangelo, pretendono dei segni o delle prove concrete per credere nel paradiso. Come non ci sono delle prove prima di entrare in questo mondo, così non ci sono delle garanzie palpabili su come sarà l’aldilà. La fede è credere alla promessa di Gesù: “Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se è morto, vivrà” (Gv 1,25).
Gesù stesso nel suo insegnamento non ha descritto come sarà il paradiso, lo ha paragonato ad un banchetto, ad una festa di nozze.
Anche la Chiesa nel parlare di questo argomento usa sobrietà di linguaggio, perché l’eternità sfugge alle leggi del tempo e dello spazio.
L’aldilà non è un luogo, ma uno stato di comunione con Dio.
Come il bambino vive la vita come un mistero da scoprire più che non un problema da risolvere, così il cristiano è chiamato ad affidarsi a quel Dio che ha promesso: “Non abbiate paura, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).
Ci si prepara all’aldilà praticando il vangelo nell’al di qua.
Pluralità di lutti: problemi e risorse
La fede aiuta a sopportare il distacco da una persona cara in vista di un destino futuro, ma il dolore del distacco rimane.



Il venerdì santo o il viaggio nella solitudine per chi resta non dura tre giorni, ma mesi e, talvolta, anni. Un ruolo particolare nell’elaborazione del cordoglio è caratterizzato dalle cause di morte, che possono riguardare un aborto spontaneo o procurato, una malattia cronica o terminale, o fatti del tutto imprevisti e laceranti, quali un ictus, un infarto, un incidente stradale o sul lavoro, un suicidio o omicidio. Ogni circostanza luttuosa comporta diverse reazioni e stati d’animo influenzati a loro volta dal contesto culturale, dal supporto esterno disponibile e dalle risorse dei protagonisti, in particolare dagli atteggiamenti assunti dinanzi alla perdita.
Il lutto in sé non è una malattia, ma un “fattore di rischio “per la salute.
I costi del lutto gravano sul bilancio sanitario attraverso l’insorgenza di patologie (ipertensione, tumori, depressione, malattie psichiche…), perdita di produttività nel lavoro (assenze, dipendenza dall’alcol o dai farmaci…), problemi esistenziali (deterioramento dello stile di vita, solitudine, isolamento…).
Società e Chiesa sono chiamate ad intervenire e a collaborare, attraverso i professionisti della salute, i servizi sociali e i centri di ascolto, per contenere i costi del lutto e promuovere la salute dei feriti.
In particolare, la Chiesa, le comunità religiose, il volontariato, i vicini di casa, sono chiamati a praticare la quarta opera di misericordia “consolare gli afflitti”, evitando quegli stereotipi di consolazione che mortificano il senso della prossimità cristiana.
L’arte di saper accompagnare chi è in lutto richiede umiltà, discrezione e competenza emotiva.
La prima forma di conforto è costituita dalla presenza, non dalle parole.
Ci si rende prossimi attraverso una visita, una chiamata telefonica, l’offerta di accompagnare chi è nel cordoglio al cimitero, ad un gruppo di preghiera, al supermercato o a fare una passeggiata.
Nei vissuti luttuosi, specie se drammatici, il processo di guarigione si fa strada lentamente, per cui ci si avvicina a loro con delicatezza consentendo il pianto e gli sfoghi di amarezza, dando spazio alle domande e allo 


Il farmaco che allevia l’afflizione è l’ascolto di ciò che l’altro sente, pensa, sperimenta.
Il termine che interpreta la capacità di saper mettersi in sintonia con chi soffre si chiama “empatia”, che designa l’attitudine ad accogliere gli stati d’animo e i pensieri dell’altro senza contrastarli, relativizzarli o banalizzarli.
L’attuale periodo storico, segnato dal Covid-19, ha palesato quanto siano fragili le nostre sicurezze e quanto sia essenziale consolidare forme e gesti di solidarietà, per attraversare insieme il lungo tunnel della pandemia.
La Chiesa, seguendo l’esempio del suo maestro, da sempre è in prima linea nel soccorrere i deboli, vestire gli ignudi, sfamare gli affamati, consolare gli afflitti.
Al di là del contagio e delle sue vittime, ogni comunità, famiglia e persona – nel corso del tempo – si trova a fronteggiare un fardello di perdite e distacchi.
La comunità o la parrocchia diventa sanante nella misura in cui, al suo interno, si consolida il numero di persone motivate e preparate a versare il balsamo della consolazione sulle ferite di chi ha sperimentato distacchi dolorosi.
Lao Tse, filosofo del VI secolo a.C. e fondatore del taoismo, suggeriva che: “Chiunque voglia portare la luce, deve conoscere le tenebre che sta per rischiarare”.
Con frequenza, chi desidera portare la luce del conforto si lascia condizionare dalla frettolosità, dal bisogno di contestare le emozioni e i pensieri di chi è nel cordoglio, dall’urgenza di dettare la propria tabella di marcia o la propria agenda a chi soffre.
Non essere “consolatori molesti” (Gb 16,2)



La pratica della vera misericordia consiglia di arginare l’affanno consolatorio di queste persone bene intenzionate, vestite di tendenze predicatorie o portatrici di facili formule rassicuranti, quale preludio per addentrarsi saggiamente nei paesaggi luttuosi.
Per calarci nella concretezza di incontri quotidiani, si prospettano di seguito un ventaglio di stereotipi o quattro tipi di comportamenti ricorrenti su cui vigilare perché potrebbero ferire invece di confortare chi è in lutto.
- Espressioni tese a smorzare i sentimenti, quali: “Non piangere”; “Non sentirti così”; “Non arrabbiarti”; “Piangere sul passato non serve a niente”; “Cerca di mantenerti calma”. Il rischio è di soffocare o giudicare i sentimenti, invece di accoglierli e comprenderli.
In pratica l’aiutante agisce come un pompiere che getta acqua sul fuoco, spesso perché il silenzio lo disturba o è a disagio nel gestire le proprie emozioni ed esige, in qualche modo, che il dolente faccia altrettanto reprimendole o ignorandole.
- Espressioni che fanno leva sui valori, quali: “Devi essere forte per i tuoi figli”; “Chi crede in Dio, non piange”; “Pensa a chi soffre più di te”; “Stai tranquillo, il tempo guarisce tutto”; “Pensa ad altro, non al tuo dolore”; “Devi solo guardare avanti”.
Certamente i valori, quali la fede, le responsabilità famigliari, il coraggio e così via rivestono un ruolo importante nel recupero da un lutto, ma non eludendo o bypassando i sentimenti o accelerando i processi di guarigione di chi è lacerato e sconvolto.
- Espressioni tese a trasmettere speranza, quali dire a una madre che ha perso una creatura in gravidanza: “È stato meglio così, ora non soffre più” oppure “Avrà presto altri bambini”; o ad una giovane vedova: “Sei bella, ti sposerai di nuovo”; o ad una coppia di genitori che ha perso un figlio: “Siete fortunati che avete un angelo in cielo che vi protegge”, oppure “Dovete ringraziare per la figlia che vi resta”. L’intento del consolatore è di riscattare gli elementi positivi della situazione, invece di vegliare nel venerdì santo di chi è addolorato; in pratica cerca di addolcire il boccone amaro somministrando iniezioni di speranza spesso inopportune o premature per mitigare lo sconforto.
- Espressioni religiose per trasformare o sublimare il dolore, quali: “Dio sa cosa è meglio per noi”; “È stata la volontà di Dio”; “Dio aveva bisogno di lui”; “Dio prende i fiori più belli per il suo giardino”; “Non cade foglia che Dio non voglia”.
Queste frasi, pronunciate talvolta dal pulpito o da consolatori infervorati religiosamente, potrebbero risultare una pessima pubblicità per Dio percepito come colui che ha mandato una leucemia ad un bambino oppure ha deciso la morte di un giovane in un incidente o come il Dio che ignora le suppliche di una famiglia che invoca la guarigione di un proprio caro. Il rischio è di presentare Dio come crudele e intento a turbare la pace e la gioia dei suoi figli.
Può, di fatto, accadere che i destinatari di questi messaggi, sconvolti da simili espressioni, decidano di abbandonare la Chiesa, amareggiati da queste proposte improvvide dell’intervento divino.
La terapia della comprensione
“Se vuoi essere più vicino a Dio, diceva Gibran, stai più vicino alle persone”.
Si lenisce il dolore permettendo a chi è in lutto di parlare del proprio amore, sapendo che anche Gesù ha pianto alla morte dell’amico Lazzaro. Le lacrime non sono segno di debolezza, ma di amore.
La verbalizzazione di impulsi di rabbia e protesta non significa che chi è nel cordoglio ha tagliato il rapporto con Dio, ma che questi stati d’animo scaturiscono dall’impatto con il senso di impotenza e dalla frustrazione per una 


Il rimorso e il rammarico trasmessi dai superstiti per errori commessi, cose incompiute o opportunità perdute sono confessioni spontanee da accogliere, senza affrettarsi a frenarle o soffocarle.
L’invito a quanti desiderano farsi prossimi a chi è nel dolore è di ricordarsi che il cammino per trasformare la “disgrazia in grazia” è lungo e tortuoso.
Dio si rende presente e consola gli afflitti servendosi di buoni consolatori.
Chi consola è, innanzitutto, una persona che ha sperimentato la consolazione di sentirsi amato e guarito da Dio: “Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio” (2 Cor 1,3-6).
Il dolore si lenisce attraverso la presenza benefica, l’ascolto attento, parole che nascono dal cuore e un mosaico di piccoli gesti che testimoniano la prossimità e la speranza.
Nelle parole di santa Teresa di Calcutta: “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”. Il dolore – per chi aiuta e chi è aiutato – è una scuola impegnativa, ma preziosa per rinnovare e accrescere la propria capacità di amare.
Arnaldo Pangrazzi – Guidami a trasformare la dis-grazia in grazia