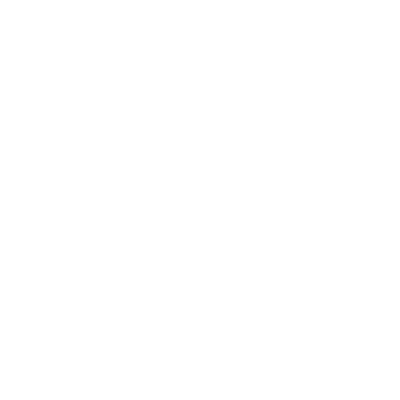di Saverio Cannistrà, ocd

Voglio innanzitutto confessare il mio imbarazzo nel trovarmi da questa parte del tavolo, cioè dalla parte di chi parla, espone, comunica, piuttosto che dalla parte di chi ascolta. Se evidentemente sono onorato di essere stato invitato a rivolgervi una parola, carissimi fratelli, devo, tuttavia, dichiarare sinceramente che temo di non avere molto da dire, e questo per almeno tre ragioni:
1) A causa del pubblico, che ne sa più di me;
2) A causa del mio trovarmi in una situazione ben più di ricerca che di possesso di certezze;
3) A causa del tema, o perlomeno della sua formulazione.
Non potendo sopprimere le prime due difficoltà, mi sono impegnato nel ridurre la terza, e questo ha richiesto un percorso un po’ lungo, che cercherò di sintetizzare, sperando di non abusare troppo della vostra pazienza.
Il problema del linguaggio
Dicevo che quando mi è stato chiesto di affrontare il tema “radicalità e profetismo nella vita consacrata”, mi sono interrogato a lungo su che cosa esattamente ci si attendesse da me. Che dovessi parlare della vita consacrata mi era chiaro. Non altrettanto chiaro mi risultava il binomio radicalità-profetismo, sia perché non veniva esplicitato che cosa si intendesse con questi due termini, sia – e ancor di più – perché non era evidente (almeno per me) quale tipo di legame logico si supponesse esistere tra di essi (radicalità e profetismo, dalla radicalità al profetismo, non radicalità, ma profetismo, e finalmente “radicalità nel profetismo”).
Non è la prima volta che mi trovo in questo genere di perplessità. Oggi, quando ci è chiesto di “pensare la vita”, ossia di riflettere su di essa per cercare di comprenderne le strutture di senso, gli intrecci o le intersezioni di campi, le incoerenze e le zone grigie, ci imbattiamo spesso in un problema preliminare, che è quello del linguaggio e della comunicazione. In effetti, per parlare delle cose usiamo parole, ma – come ci hanno insegnato da più di un secolo la linguistica e la semiotica – il rapporto tra le parole (i segni) che usiamo e le realtà (le cose) a cui facciamo riferimento non è diretto. La parola o il segno raggiunge la cosa solo attraverso una sua “interpretazione”, che è ciò che chiamiamo normalmente “significato” (molti di noi ricorderanno il famoso triangolo semiotico di Ogden e Richards, nella loro opera del 1923, The Meaning of Meaning). È questo percorso che rende possibile il processo di codificazione del parlante e di decodificazione del ricevente. Cercando di semplificare al massimo, il parlante parte dalla cosa, la “pensa”, ossia la traduce in un contenuto concettuale, che finalmente esprime in segni grafici e fonetici. L’ascoltatore, perché la comunicazione funzioni, deve fare il percorso inverso, ossia partendo dai segni, dalle parole, coglie l’interpretazione concettuale e così identifica la cosa.
La corretta decrittazione del significato di un segno è qualcosa di più o meno evidente o scontato in due forme di linguaggio: quello della lingua di ogni giorno (per cui vale il riferimento al dizionario, ossia all’uso corrente della lingua) e quello dei linguaggi tecnici, dove a ogni parola corrisponde un preciso significato codificato. Sono in qualche modo due estremi: quello della lingua naturale, materna, che parliamo “senza pensarci”, e quello di una lingua artificiale, in cui ogni parola è come la cifra abbreviata di un ragionamento a cui si rimanda.



Resta l’alternativa “povera” del linguaggio quotidiano, che è sicuramente praticabile, visto che Gesù lo ha fatto nel vangelo. È un modo di parlare per parabole, per immagini, per racconti di esperienze vissute. Questo tipo di gioco linguistico consente di aggirare l’ostacolo della concettualizzazione, o per meglio dire dell’accordo comunicativo sui concetti che usiamo. Per esempio, un mio carissimo confratello, P. Miguel Márquez, ha tenuto una conferenza sulla vita contemplativa ai religiosi e religiose durante la settimana di chiusura dell’anno della vita consacrata, in un linguaggio non concettuale: ha usato immagini, raccontato episodi di vita, presentato alcune figure, proposto “sette danze”, invitato al silenzio, impartito una benedizione. Il risultato è stato una eccellente comunicazione: il messaggio è passato dall’emittente al destinatario, con la sua ricchezza di connotazioni non facilmente concettualizzabili, grazie all’uso sapiente di icone e simboli (che, in questo caso, distinguo dai segni, proprio per il loro rapporto immediato, evocativo della cosa).
Ai più, e comunque al sottoscritto, che non brilla per particolare fantasia e creatività letteraria, non resta, tuttavia, che percorrere una sorta di via di mezzo, tra il linguaggio quotidiano e quello tecnico, e cioè la via di un linguaggio concettuale che si va costruendo faticosamente e progressivamente, cercando di coinvolgere l’uditorio in una alleanza o complicità comunicativa. È questa direi la grossa fatica di fronte a cui ci troviamo oggi quando siamo costretti a pensare e a parlare della nostra vita: dobbiamo costruirci gradino per gradino la scala per quale vogliamo salire o scendere.
Salva