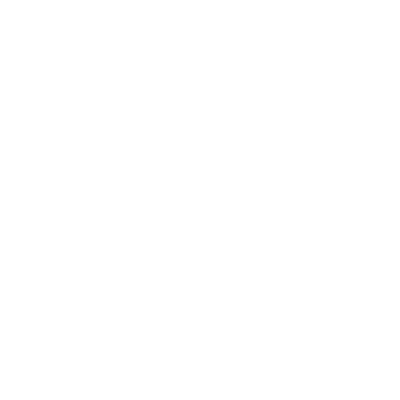“Avvinti dallo Spirito” (At 20, 7-38)
 Concludiamo con due narrazioni di “addio”. Possiamo allora considerare questa ultima riflessione una sorta di “viatico”. Un ulteriore scorta di “cibo” per il nostro cammino. I cristiani di Troade si ritrovano con Paolo per l’ultima volta (ai vv7-12). L’apostolo e i suoi amici non si rivedranno più. Non sono descritti il pathos e la commozione che troveremo poco dopo, nel commiato agli anziani di Efeso al porto di Mileto; con grande discrezione, tuttavia, Luca ci fa entrare nel cuore di Paolo e di questa piccola comunità che l’ha accolto e gli ha voluto bene. I cristiani di Troade, dunque, trattengono Paolo una notte intera perché sanno che deve partire e che non lo vedranno più. È l’ora dell’addio, e tante sono le cose da chiedere e da raccontare, le domande da porre, le questioni da sciogliere. Vorrebbero che non se ne andasse, ma sanno di non poterlo trattenere; e lottando contro il sonno si regalano un’ultima notte per ascoltare la parola e celebrare l’eucaristia, per ritrovarsi tra fratelli e confortarsi e rafforzarsi nella fede.
Concludiamo con due narrazioni di “addio”. Possiamo allora considerare questa ultima riflessione una sorta di “viatico”. Un ulteriore scorta di “cibo” per il nostro cammino. I cristiani di Troade si ritrovano con Paolo per l’ultima volta (ai vv7-12). L’apostolo e i suoi amici non si rivedranno più. Non sono descritti il pathos e la commozione che troveremo poco dopo, nel commiato agli anziani di Efeso al porto di Mileto; con grande discrezione, tuttavia, Luca ci fa entrare nel cuore di Paolo e di questa piccola comunità che l’ha accolto e gli ha voluto bene. I cristiani di Troade, dunque, trattengono Paolo una notte intera perché sanno che deve partire e che non lo vedranno più. È l’ora dell’addio, e tante sono le cose da chiedere e da raccontare, le domande da porre, le questioni da sciogliere. Vorrebbero che non se ne andasse, ma sanno di non poterlo trattenere; e lottando contro il sonno si regalano un’ultima notte per ascoltare la parola e celebrare l’eucaristia, per ritrovarsi tra fratelli e confortarsi e rafforzarsi nella fede.
In primo luogo ci sentiamo invitati a fare tesoro delle persone che abbiamo accanto, della loro presenza, della ricchezza del loro cuore. Non sappiamo per quanto tempo il Signore ce le lascerà vicino, non sappiamo se ci sarà ancora possibile vederle, sentirle, toccarle…
E ci piacerebbe poterle salutare senza tanti rimpianti, senza nostalgie paralizzanti, serbando nel cuore ricordi a volte segnati da un filo di malinconia ma sempre e comunque da un capitale di gratitudine. È un vero peccato, a distanza di tempo, dover riconoscere che non abbiamo compreso o apprezzato abbastanza la presenza di un confratello che ci ha lasciato: invano proviamo a ricostruire i contorni dei nostri rapporti, gli episodi che hanno caratterizzato i nostri incontri, le frasi che ci hanno segnato e colpito. Sentiamo che molto sfugge alla nostra memoria labile, perfino quando possiamo rivedere le immagini e risentire le parole che hanno suggellato la nostra amicizia. Niente restituisce la presenza viva, il potersi toccare, guardare negli occhi, vivere fianco a fianco i medesimi sentimenti. È fonte di pace, in queste circostanze, sapere di aver goduto e gustato della presenza dell’altro, di aver usato bene le possibilità che ci sono state regalate per tenercelo stretto senza soffocarlo, per amarlo senza renderlo schiavo.
Questo testo ci insegna l’importanza di imparare a dire addio.
Il momento del saluto è sempre molto delicato. Non solo quello dell’estremo saluto, della nostra morte, che è radicalmente indisponibile ai nostri calcoli nei tempi e nei modi in cui dovrà avvenire. Non sapremo se moriremo rasserenati o sconfitti, in un letto o su una strada, nel sonno o dopo una lunga agonia… Ma prima dell’estremo saluto ce ne sono molti altri. Siamo chiamati a lasciare il padre e la madre; capita di cambiare città o paese, ministero o scuola, di abbandonare una comunità, di ricominciare da capo in un luogo fino a poco prima completamente sconosciuto. Ci sono rapporti nei quali ci ritroviamo invischiati, non liberi, non limpidi, rapporti in cui diviene alto il rischio di usare l’altro (o di lasciarsi usare, consapevolmente da lui).Ce ne sono altri rispetto ai quali non si ha il coraggio di riconoscere che le condizioni di partenza sono mutate: la relazione di aiuto è diventata storia affettiva, l’accompagnamento spirituale si è trasformato in un reciproco infruttuoso specchiarsi nell’altro, la stima e l’affetto sono




naufragate nel culto della persona, la riconoscenza si è trasformata in schiavitù, come se tutta la vita fosse un debito da pagare…
Il campionario è infinito, lo sappiamo bene.
Chiedere il dono della chiarezza, in queste circostanze, significa anche domandare la grazia del saluto, la forza di saper chiudere per imparare a camminare di nuovo. Ancora oggi, in diverse circostanze, si usa fare ciò che hanno fatto Paolo e i credenti di Troade: suggellare un momento importante con la celebrazione dell’eucaristia. Ma le nostre eucaristie commemorative, o di fine anno, o di saluto al confratello che parte, in realtà hanno poco di che spartire nei tempi e nei modi con quella celebrata a Troade. Nella narrazione di Atti ritroviamo alcuni elementi caratteristici degli incontri dei primi cristiani: la stanza al piano superiore, l’ascolto della parola, lo spezzare del pane, il primo giorno della settimana.
Il luogo, come il cenacolo, anche questa stanza è «elevata»; non ci è dato di sapere se questa collocazione è del tutto casuale, ma è ad ogni modo significativa: ribadisce la necessità dello «stacco» e della distanza, della quiete e del silenzio che devono accompagnare ogni celebrazione. È interessante anche il tempo in cui avviene il rito: al termine di una giornata di lavoro, con tanta stanchezza addosso.
Ma di questo lungo rendimento di grazie non ci sono descritti soltanto gli elementi «esterni». Luca ci fa intravvedere anche i sentimenti di questa comunità. La prima è il desiderio di riunirsi. Se c’è una cosa che appare con chiarezza in questo brano di Atti, è che questa comunità ha voglia di stare insieme.



Al centro di tutta la celebrazione notturna di Troade stanno l’annuncio della parola e lo spezzare del pane. Il resto è contorno. La parola è annunciata con un’abbondanza che ci verrebbe da dire esagerata. Paolo non la smette più di parlare. Da una parte c’è un uomo che parla, Paolo, ma dall’altra c’è una parola che “governa” quest’uomo, che «lo agisce», diremmo (forzando la grammatica italiana), che lo governa, che lo ha conquistato. È essa stessa a conservare, a far crescere, a trasformare la realtà di chi se ne lascia toccare e conquistare. A partire da queste considerazioni, il Cardinal Martini offre dei suggerimenti concreti per entrare nel segreto della comunicazione efficace della parola, riassumendoli in tre passaggi.
Il primo: «dal cuore».
«La predica cristiana nasce dall’interiorità, dalla mia convinzione profonda e anche dalle mie sofferenze profonde. Per entrare nel cuore dobbiamo fare un certo cammino, perché non è facile pescare nella propria interiorità: ci vuole un tempo di riflessione. Spesso la predicazione cristiana dà l’impressione di una qualche superficialità e ripetitività, e la gente si accorge che le cose spesso non sono state sofferte, macerate, vissute».
Il secondo: «il cuore».
«C’è il cuore di ogni esposizione orale e scritta che voglia avere un senso, una consistenza. Se non c’è, il predicatore divaga, le frasi riescono sfilacciate, poste una accanto all’altra senza capire cosa veramente si intende comunicare. Occorre cercare il cuore, sforzarsi di trovare qual è il messaggio che veramente mi sta a cuore di comunicare».
Il terzo: «al cuore».
«La comunicazione dovrebbe poter raggiungere ciò che la persona vive o vorrebbe vivere nella sua interiorità. Interiorità nel suo significato ampio: slanci verso Dio e smarrimenti interiori, angosce, tenebre, paure. Ciò che conta è di arrivare a questo cuore della persona. Non si tratta di trasformare il mio linguaggio travestendolo o traducendolo, bensì di partire dalla mia interiorità che è identica, nei suoi travagli, sofferenze, aspirazioni, a quella di tutti gli uomini, senza eccezione».